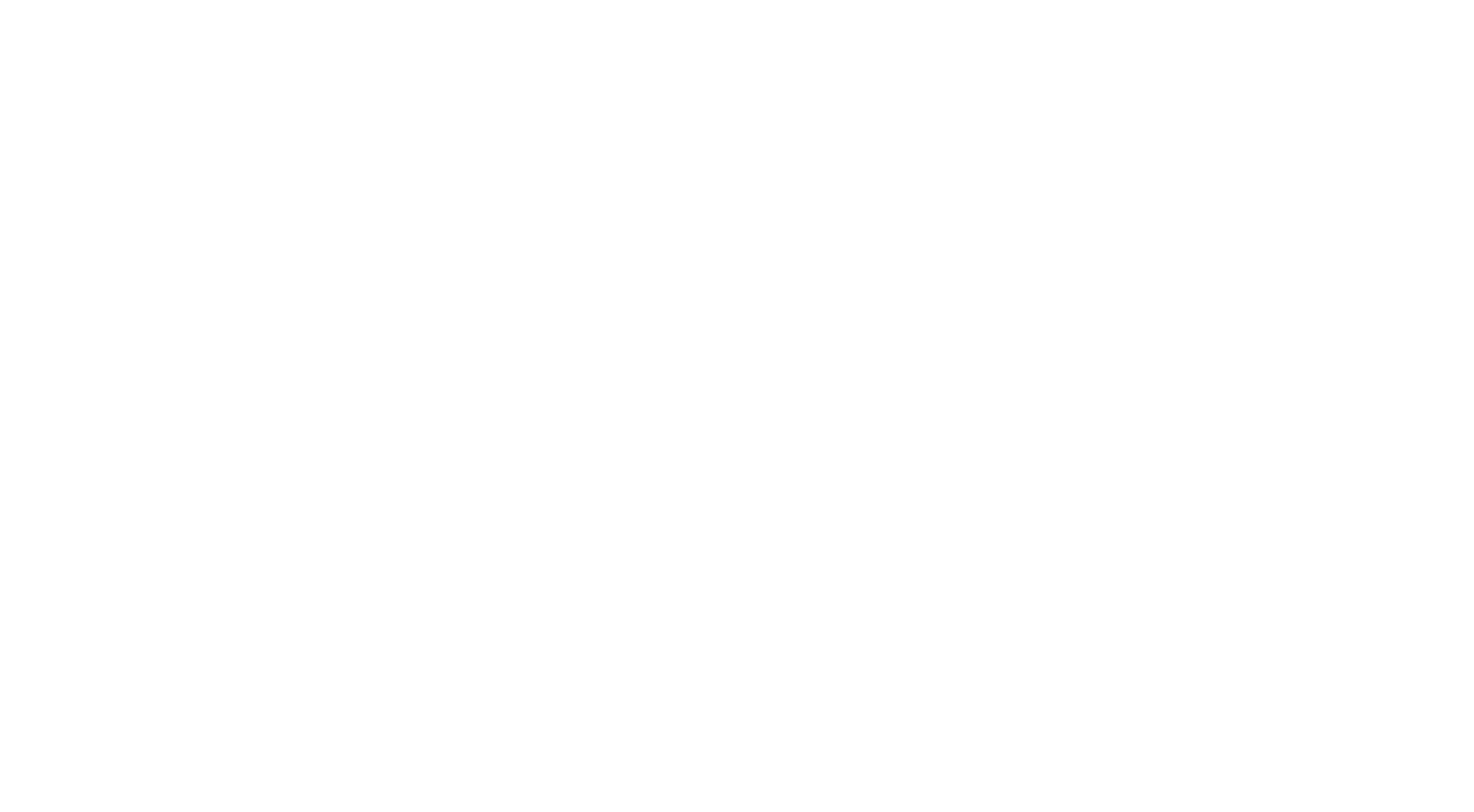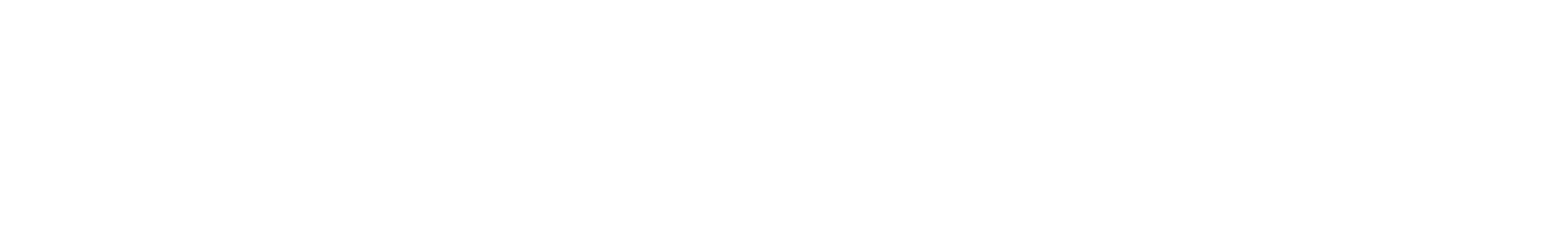Il 26 novembre 2025 si è svolta, presso la Sala Molajoli della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la presentazione delle Linee Guida per l’azione amministrativa e tecnico-scientifica sul patrimonio demoetnoantropologico e immateriale, pubblicate tramite la Circolare DG ABAP n. 21 del 16 aprile 2025, e aventi l’obiettivo di conferire omogeneità, efficienza ed efficacia alle attività del Ministero della Cultura (MIC) in questo settore. Scopo della giornata, a cui ha partecipato un alto numero di funzionari afferenti principalmente agli istituti periferici del Ministero, in presenza e a distanza, era quello di rendere tale strumento pienamente operativo nell’attività amministrativa sui territori.
Le linee guida sono dirette ai funzionari operanti nell’area funzionale V “patrimonio demoetnoantropologico e immateriale” delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP), ma sono uno strumento disponibile per tutti i funzionari del MIC che si occupano di tale ambito del patrimonio culturale o che beneficiano di un approccio interdisciplinare.
Frutto del lavoro avviato nel 2021 da un composito Gruppo di lavoro coordinato da dal prof. Leandro Ventura, Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI), e dalla prof.ssa Elena Calandra, già Dirigente del Servizio II e Dirigente ad interim del Servizio VI DG ABAP, e sotto la responsabilità scientifica delle funzionarie demoetnoantropologhe dott.ssa Valeria Trupiano e della dott.ssa Alessia Villanucci, le linee guida approfondiscono i principali ambiti di azione amministrativa e tecnico-scientifica sul patrimonio demetnoantropologico e immateriale attraverso una trattazione divisa in cinque paragrafi, ciascuno dei quali corredato da una selezione di schede dedicate a casi di studio particolarmente rilevanti in relazione al tema trattato.
- Il primo, “Definizione di bene etnoantropologico”, fornisce gli strumenti concettuali utili a individuare il patrimonio di interesse etnoantropologico e immateriale e a delimitare i confini dell’azione amministrativa in questo ambito, suggerendo al contempo possibilità di lavoro finora inedite.
- Il secondo, “Individuazione dei beni etnoantropologici e delle espressioni di identità culturale collettiva”, tratta in dettaglio i procedimenti di verifica e di dichiarazione dell’interesse culturale, ponendo particolare attenzione alle metodologie scientifiche e alle opportune prassi amministrative da osservare nei confronti dei beni di interesse etnoantropologico (ex. art. 10) e delle testimonianze materiali di identità culturale collettiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 10 del D.Lgs. 42/2004.
- Il terzo, “Conservazione dei beni etnoantropologici”, esamina il tema del restauro dei beni etnoantropologici o aventi più profili di interesse, tra i quali anche quest’ultimo.
- Il quarto, “Paesaggio, patrimonio demoetnoantropologico e patrimonio immateriale”, è dedicato a una fattispecie patrimoniale, quella paesaggistica, non direttamente definibile “di interesse etnoantropologico”, ma fortemente caratterizzata da definizioni e orientamenti coerenti con le prospettive dell’antropologia culturale. Il testo mette in luce come gli strumenti metodologici e interpretativi che caratterizzano la disciplina nel suo insieme possano apportare un significativo contributo all’individuazione e alla tutela degli elementi paesaggistici e dei valori oggetto di interesse.
- Infine, il quinto paragrafo è dedicato all’individuazione di “Concetti e strumenti utili alle azioni sul patrimonio culturale immateriale”, con particolare attenzione alle attività di salvaguardia, a livello nazionale, dello stesso, indipendenti dalle procedure relative alle liste UNESCO. Tali concetti, strumenti e azioni sono attinti non solo dal D.Lgs. 42/2004, ma anche e soprattutto dalle convenzioni internazionali che costituiscono le principali fonti normative in questo settore.
La giornata si è aperta con i saluti istituzionali e le introduzioni dell’arch. Laura Moro, dirigente del Servizio II del Dipartimento Tutela, in rappresentanza del dott. Luigi La Rocca, Capo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale; del dott. Fabrizio Magani, Direttore Generale ABAP; del prof. Leandro Ventura e la prof.ssa Elena Calandra, Coordinatori del gruppo di lavoro sulle Linee guida; della dott.ssa Valeria Trupiano e della dott.ssa Alessia Villanucci, Responsabili scientifiche delle Linee guida; e della dott.ssa Gabriella Carpentiero, funzionaria della Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in rappresentanza dell’arch. Gabriele Nannetti, Soprintendente ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.
La sessione sulla Definizione di bene etnoantropologico ha visto gli interventi del dott. Vito Lattanzi, già funzionario del MUCIV-Museo delle Civiltà, e della dott.ssa Elena Musumeci, funzionaria dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
La parte dedicata alla Tutela è stata curata dall’arch. Cristina Bartolini, Dirigente DG ABAP-Servizio III, dalla dott.ssa Valeria Trupiano, funzionaria dell’ICPI, e dal dott. Marcello Moscone, funzionario della DG Archivi.
Gli interventi sul Restauro sono stati condotti dall’arch. Luigi Oliva, Direttore ICR, dalla dott.ssa Valentina Santonico, funzionaria dell’ICPI, e dalle dott.sse Giulia Cervi e Serena Francone, funzionarie del Museo delle Civiltà.
La sessione sul Paesaggio è stata tenuta dall’arch. Isabella Fera, Dirigente DG ABAP-Servizio V, dalla dott.ssa Mariantonia Crudo, funzionaria della Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara, e dalla dott.ssa Giuliana Aiello, funzionaria della DG ABAP.
La parte dedicata alla Salvaguardia è stata trattata dal prof. Leandro Ventura, dalla dott.ssa Alessia Villanucci e dal dott. Claudio Rizzoni, entrambi funzionari dell’ICPI.
A conclusione della mattinata, è stata inaugurata la mostra Palio 365, allestita nel Complesso Monumentale del San Michele a Ripa Grande su progettazione dell’arch. Francesco Paolo Quaranta, funzionario dell’ICPI, con le fotografie di Massimo Cutrupi e Katia Ballacchino. Già presentata a Siena presso il Complesso Museale del Santa Maria della Scala da novembre 2024 a marzo 2025, l’esposizione ha lo scopo di raccontare il processo che ha portato al riconoscimento del Palio di Siena come “espressione di identità culturale collettiva” attraverso l’individuazione e la tutela di 23 testimonianze materiali (ai sensi degli artt. 10 e 7 bis del D.Lgs. 42/2004) – bandiere e tamburi – illustrate nei pannelli.
La mostra rappresenta anche un’opportunità per far conoscere la ricchezza delle storie e dei legami che animano la vita di Contrada durante i 365 giorni dell’anno, non solo nei giorni della festa.
Le introduzioni delle dott.sse Gabriella Carpentiero, Valeria Trupiano e Alessia Villanucci hanno accompagnato i visitatori nella scoperta dei contenuti esposti, illustrando il valore culturale e la rilevanza del patrimonio demoetnoantropologico e immateriale presentato.